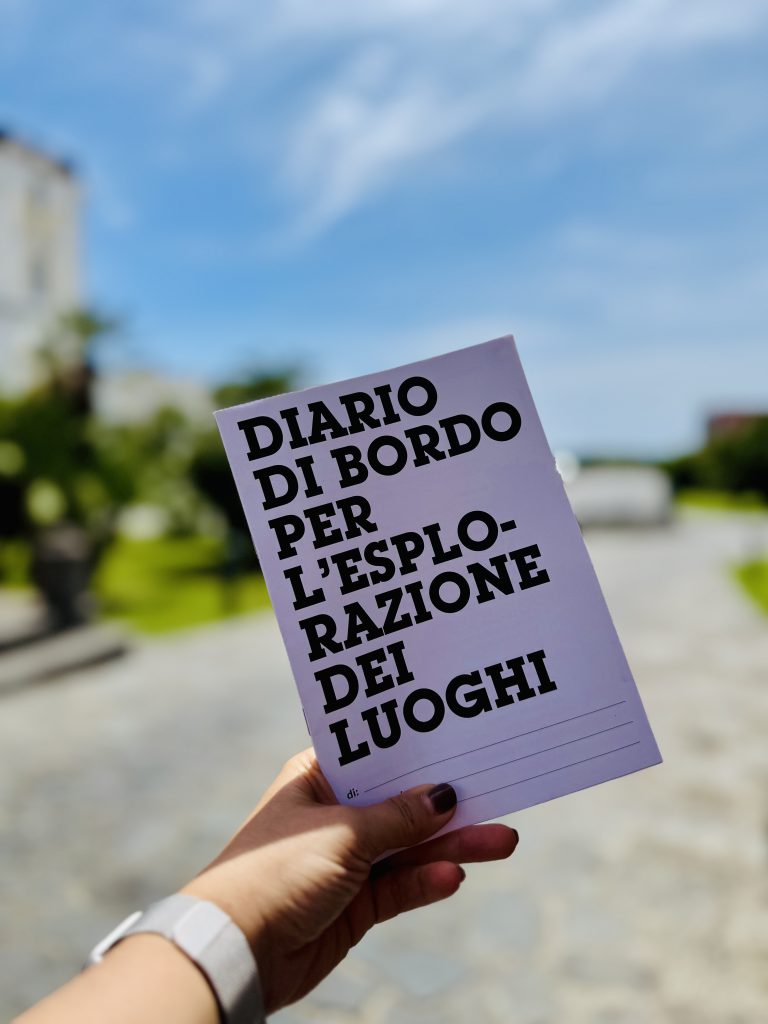Napoli ed Ercolano con Lo Stato dei Luoghi: il diario di Grazia
Come sapete , dal 22 al 25 maggio 2025 abbiamo attraversato Napoli e i suoi margini iniziando da Ercolano, guidatə da Lo Stato dei Luoghi e dal desiderio di incontrare chi abita e rigenera spazi con visione, cura e coraggio.
Dopo avervi presentato, giorno dopo giorno, le impressioni e i pensieri di chi ha partecipato al percorso di accompagnamento Lo Stato dei Luoghi Comuni, ci avviciniamo al resoconto corale. Prima però vi proponiamo il diario sensibile e immersivo di Grazia Longo da Hubit di Bitetto (BA) che introduce le atmosfere, le emozioni e le riflessioni collettive nate durante questa esperienza.
Ed ecco di seguito le pagine di diario che Grazia condivide con tutte e tutti noi!
Napoli: un diario dal 22 al 25 maggio
22 maggio – Ercolano (o Resina)
Il primo morso del “cuzzetiello” si imprime sulla bocca dello stomaco: da subito capisco che questo non sarà un viaggio per vedere, ma per sentire. Il sole batte forte su Villa Campolieto – ve la consiglio – ci aspettavamo un luogo marginale, invece Ercolano si è presentata in tutto il suo splendore. Non siamo venuti per le rovine, ma per ciò che resiste.
La Villa è un palazzo antico che ospita Variabile K, un’impresa sociale il cui nome stesso è un ossimoro che contiene una filosofia: “variabile”, come ciò che cambia, e “K”, che nel linguaggio matematico rappresenta una costante. Il segno di una visione che vuole tenere insieme instabilità e continuità.
Ogni piccola stanza, a loro affidata, del palazzo è un’officina di futuro: una falegnameria, un forno per ceramica, una stampante 3D: se lo spazio non c’è, lo si crea (è una visione che condividiamo anche noi baresi). Facciamo un giro tra gli spazi rigenerati, incontriamo Ciro con il suo carretto di granite – obbligatorio fermarsi – lo ha costruito con le sue mani, fa tutto da solo. Non solo uno strumento di lavoro, ma un manifesto mobile di possibilità.
Luigi, Ottavia e gli altri ci parlano di un urbanismo tattico come strumento concreto di immaginazione e partecipazione sociale, contro la cultura dei “microghetti”, dove le rivalità tra clan sono antiche come le pietre. Si riscrive la geografia urbana: un quartiere può cambiare solo se lo si guarda come qualcosa che ci appartiene.
Quello che mi porto dentro: c’è qualcuno che semina costanza dentro l’instabilità.
23 maggio – Napoli
Il giorno dopo è Napoli a chiamarci, e lo fa dai suoi luoghi più feriti. Entriamo nei Quartieri Spagnoli, cuore pulsante e cicatrice viva della città. È qui che si trova FOQUS, Fondazione Quartieri Spagnoli, il cui nome oggi è un punto di riferimento nazionale nel campo della rigenerazione urbana e sociale. Ad accoglierci è Renato Quaglia, che ci introduce alla storia controversa di questi luoghi: qui la luce elettrica è arrivata solo nel 1995.
Mi torna in mente Matilde Serao, “Il Ventre di Napoli”, quando parlava della città “di sotto”, sconosciuta alla città “di sopra”. Oggi, quella Napoli è ancora viva e Quaglia la conosce bene. Le sue riflessioni colpiscono per la lucidità:
“Il Novecento è stato il secolo dei progetti, il nostro è il secolo delle riparazioni. Ma rammendare significa solo nascondere lo strappo: noi dobbiamo mostrarlo, come fa il kintsugi giapponese, che evidenzia le fratture con l’oro.”
Il modello va trasformato, non sistemato. E allora FOQUS lavora per creare autonomia, non assistenza. “È necessario comprendere che quando si fa un progetto in aree di fragilità, bisogna avere il coraggio, la forza, l’umiltà di produrre un vuoto”. Eppure qui è tutto pieno: gli spazi verticali della scuola paritaria, l’orto condiviso, i terrazzi pieni di bambini che giocano. Tutto è orientato a restituire dignità e partecipazione. Durante la visita, uno dei piccoli studenti ci guarda e esclama: “Ci sono gli ospiti illustri.” E io mi sento piccola, onorata, fuori posto e proprio per questo, dentro tutto.
Subito dopo visitiamo Le Catacombe di San Gennaro, un luogo che Napoli ha imparato a custodire con amore e ironia. Del miracolo del sangue si dice: “Non è vero, però ci credo”. È così Napoli: logica e mistica, scettica e credente, tutta insieme.
A prendersene cura è la cooperativa La Paranza, che ci parla di un patrimonio non come oggetto da proteggere, ma come occasione di riscatto. Le catacombe, come il Cimitero delle Fontanelle che rinascerà con un progetto di Renzo Piano, sono parte viva della città. Il loro lavoro parte dalla vocazione naturale delle comunità, dei luoghi, delle persone. Non si impone nulla: si ascolta, si accompagna.
E poi, nel cuore della Napoli più intrecciata, visitiamo Dedalus nelle Officine Gomitoli, dove il presente è fatto di lingue diverse, storie migranti, mani intrecciate. Qui si lavora sull’incontro tra culture, sull’integrazione reale, fatta di formazione, affiancamento e azioni quotidiane.
Nessuno ha più voglia di parlare con noi: l’aria è tesa, la città sta per esplodere. È la notte della partita dello scudetto.
Napoli trema, canta, brucia. Ogni balcone è un altare azzurro. Accanto a ogni bandiera della squadra, ne sventola una della Palestina. La commistione colpisce, il calcio qui è più che sport, è racconto collettivo, identità. È urlo.
Siamo dentro una festa che è anche dichiarazione politica. I fumogeni puzzano tantissimo. La sciarpa del Napoli è stata un acquisto utile.
24 maggio – Napoli
La mattina ci accoglie Francesca, nello spazio sospeso di Riot Studio, non riesco a togliermi dalla testa l’albero che cresce sulla scala verso il più bel terrazzo che io abbia mai visto. Un posto nato per il coworking, ma è diventato altro: casa di produzione cinematografica, laboratorio artistico, progetto culturale “indisciplinato”.
Sono curiosa, mi intrufolo un po’, la sala più grande è interamente dipinta di nero. Spazio vuoto, nero, disponibile: qui l’assenza è fertile, è apertura (hanno parlato anche loro con Renato Quaglia?). La parola d’ordine è sperimentare.
Qui si fanno concerti al tramonto, si cena tra soci, si comunica solo via citofono o newsletter.
Sul loro terrazzo, pieno di verde, si tiene la nostra riunione tra le quindici realtà pugliesi partecipanti al viaggio. Vogliamo costruire una Rete, tra chi rigenera spazi e inventa nuovi modi di stare insieme. Il progetto è promosso da Arti Puglia con Luoghi Comuni e Lo Stato dei Luoghi. Parliamo tra noi, intrecciamo, tessiamo.
Abbiamo subito fame.
Il primo pomeriggio è forse il momento più radicale: visitiamo l’Ex Asilo Filangieri, uno dei Beni Comuni di Napoli. La sua storia è straordinaria.
Occupato il 2 marzo 2012 dal collettivo La Balena – nome ispirato al movimento del grande cetaceo che si immerge in profondità per poi riemergere –, l’ex Asilo è oggi uno spazio riconosciuto come “spazio demaniale, bene comune ad uso civico e collettivo”.
Ci guida Nicola Caputo, ed ogni sua parola è un manifesto. La legge si piega all’uso, al gesto continuo e condiviso. La legge la fanno tutti.
È una comunità fluida, informale: niente associazioni, solo comitati di scopo temporanei. Qui regola è obbligo morale.
Il teatro ha le gradinate mobili, tutto è polifunzionale, flessibile. Lo spazio è pensato per trasformarsi continuamente. Si “mettono in comune i mezzi di produzione”. Si depatriarcalizzano gli spazi. Si decide per collegialità.
È un altro tempo, un altro ordine. Forse un altro possibile futuro.
Abbiamo fatto presto, incontriamo Giovanni e Anna: Teatringestazione, compagnia teatrale e ideatrice di Altofest, festival artistico che gioca con i confini tra pubblico e privato.
Gli artisti vivono nelle case dei cittadini, traducono le loro opere formali per i contesti domestici. Le persone offrono le loro abitazioni, rinunciando simbolicamente alla proprietà. Il pubblico, infine, accetta di uscire dalla “fila N, posto 5” e si responsabilizza come parte attiva dell’esperienza, l’arte è fuori dai luoghi di consumo.
Una delle signore ci racconta: “Quella casa era di mio marito. Dominata dal rigore geometrico. Quando è venuto a mancare, ancora sentivo la sua presenza. Facevo come l’acqua che cerca di adattarsi allo spazio.” E ora lo riscrive. Un altro confine che crolla. Intimo e pubblico si mescolano.
Con loro visitiamo Palazzo San Felice e poi ci inoltriamo nei Cristallini, quartiere del rione Sanità. È qui che scopriamo, nascosta in bella vista, una gigantesca cava di tufo usata come parcheggio. Ci chiediamo: quanti napoletani sanno della sua esistenza? È lì, enorme, evidente e invisibile. È Napoli: marginalità nel cuore pulsante, centro che si sente periferia.
Balliamo, mangiamo pizza con l’ananas. La giornata si chiude, per alcuni, sulla terrazza di Giovanni e Anna. Per altri, come me, la notte continua: ci imbuchiamo nella mensa occupata, camminiamo ancora tra i vicoli. È l’ultima notte, Napoli non si lascia lasciare facilmente.
25 maggio – Ripartire
La mattina ripartiamo.
Abbiamo iniziato nei margini di Ercolano, finiamo nel cuore di Napoli. Ad onor del vero non ho rubato neanche una saponetta dall’hotel, magari ci torno presto.
In questi quattro giorni abbiamo attraversato spazi fragili ma vitali, incontrato persone che abitano il confine tra ciò che è e ciò che potrebbe essere.
Abbiamo visto che rigenerare non è solo costruire, ma lasciare spazio al vuoto, fidarsi dei processi, credere senza vedere tutto finito. Abbiamo imparato che anche ciò che è rotto, può essere mostrato con dignità.
Napoli non è una città semplice. È tutto un controsenso: bambini e catacombe, vuoti neri e terrazzi pieni, case aperte e cave invisibili.
Un luogo che non si lascia capire, che però ci trasforma.
Non è vero, però ci credo.